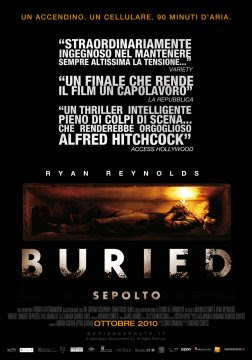Sebbene abbia ancora un aspetto attraente e vigoroso, Eastwood ha superato gli ottanta anni e anagraficamente inizia a chiedersi “cosa succede dopo la morte?”; sarà per questo che quando – tramite Steven Spielberg, produttore della pellicola – gli hanno proposto di dirigere “Hereafter” (“aldilà”, in italiano) ha accettato senza riserve. Scritto da Peter Morgan (“The Queen”, “Frost/Nixon”), il film racconta la storia di tre persone utilizzando altrettanti indipendenti binari narrativi riprendendo lo stile caro a Guillermo Arriaga (sceneggiatore della Trilogia Amores perros/21 grammi/Babel di Inarritu, ndr). Marie Lelay (Cécile de France) a Parigi è una nota giornalista francese che si è salvata per miracolo durante un tragico maremoto alle Hawaii; George Lonegan (Matt Damon) a San Francisco è un medium renitente in possesso di poteri soprannaturali; Marcus a Londra perde il suo fratellino gemello in un drammatico incidente. Vite e città distanti, condizioni socio-culturali profondamente differenti, stati d'animo contrastanti ma comunque uniti a doppio filo dalla ricerca di quel qualcosa che c'è oltre il mondo terreno: l'aldilà, vero o presunto che sia. Un tema profondo e serio, certamente difficile da maneggiare; anche se di nome fai Clint e conservi in bacheca due Oscar. Il regista americano indaga sui tormenti comuni ed esplora con tatto le credenze in materia, spingendo sull'acceleratore delle emozioni come ci ha abituati, ma in questa prova manca più di qualcosa. Innanzitutto la rappresentazione parallela, che poco si addice alla macchina da presa dell'ex Ispettore Callaghan: la coreografica sequenza iniziale dello tsunami, le lezioni culinarie di George sullo sfondo di un ristorante italiano, l'attentato nella metropolitana, sono effimeri e roboanti bagliori in una rappresentazione piuttosto incolore. E l'idea, senza dubbio apprezzabile, di inserire stralci di attualità (non solo le tragedie naturali o gli atti terroristici, ma anche il product-placement integrato o l'uso massiccio di Google) alla lunga sfiancano lo spettatore. Ognuno dei protagonisti medita e patisce un trauma interiore, vive da inquieto e disadattato la propria condizione, desidera ritrovare la propria anima o “sente” quelle altrui, però dall'altra parte dello schermo arrivano briciole di energia e bisogna accontentarsi dei fantasmi dickensiani o delle visioni paranormali del medium George. Curioso, inoltre, che Eastwood si mostri assai critico attaccando frontalmente la categoria di coloro che “parlano con i morti” catalogandoli come (giusto che sia) imbroglioni, e poi arrivi a santificare il suo protagonista sensitivo solo perché decide di smettere di lucrare con questa dote. Va detto, però, che lo sguardo del regista sa essere anche pragmatico, infatti in “Hereafter” non c'è una destinazione precisa o un prevedibile Paradiso su cui approdare, non c'è una comoda strada cattolica da seguire; anzi, il veloce e stereotipato funerale del ragazzino a Londra sembra quasi prendere le distanze con ironia dalla morale cristiana. Dell'ultimo Eastwood apprezziamo l'onesta e l'ambiziosa intenzione di riflettere con umiltà su un argomento tanto indefinibile quanto sacro e inviolabile. Progetto riuscito o tentativo mancato? Per chi scrive, come probabilmente si evince, la seconda. Ciò nonostante, alcuni potrebbero apprezzare questo viaggio contemplativo e gradire la vena malinconica del vecchio Clint; con il quale condividiamo il pensiero circa l'impossibilità di stabilire l'esistenza di un'oltretomba e per cui al di qua della terra ci auguriamo di gioire per lunghi anni ammirando le sue pellicole.
Sebbene abbia ancora un aspetto attraente e vigoroso, Eastwood ha superato gli ottanta anni e anagraficamente inizia a chiedersi “cosa succede dopo la morte?”; sarà per questo che quando – tramite Steven Spielberg, produttore della pellicola – gli hanno proposto di dirigere “Hereafter” (“aldilà”, in italiano) ha accettato senza riserve. Scritto da Peter Morgan (“The Queen”, “Frost/Nixon”), il film racconta la storia di tre persone utilizzando altrettanti indipendenti binari narrativi riprendendo lo stile caro a Guillermo Arriaga (sceneggiatore della Trilogia Amores perros/21 grammi/Babel di Inarritu, ndr). Marie Lelay (Cécile de France) a Parigi è una nota giornalista francese che si è salvata per miracolo durante un tragico maremoto alle Hawaii; George Lonegan (Matt Damon) a San Francisco è un medium renitente in possesso di poteri soprannaturali; Marcus a Londra perde il suo fratellino gemello in un drammatico incidente. Vite e città distanti, condizioni socio-culturali profondamente differenti, stati d'animo contrastanti ma comunque uniti a doppio filo dalla ricerca di quel qualcosa che c'è oltre il mondo terreno: l'aldilà, vero o presunto che sia. Un tema profondo e serio, certamente difficile da maneggiare; anche se di nome fai Clint e conservi in bacheca due Oscar. Il regista americano indaga sui tormenti comuni ed esplora con tatto le credenze in materia, spingendo sull'acceleratore delle emozioni come ci ha abituati, ma in questa prova manca più di qualcosa. Innanzitutto la rappresentazione parallela, che poco si addice alla macchina da presa dell'ex Ispettore Callaghan: la coreografica sequenza iniziale dello tsunami, le lezioni culinarie di George sullo sfondo di un ristorante italiano, l'attentato nella metropolitana, sono effimeri e roboanti bagliori in una rappresentazione piuttosto incolore. E l'idea, senza dubbio apprezzabile, di inserire stralci di attualità (non solo le tragedie naturali o gli atti terroristici, ma anche il product-placement integrato o l'uso massiccio di Google) alla lunga sfiancano lo spettatore. Ognuno dei protagonisti medita e patisce un trauma interiore, vive da inquieto e disadattato la propria condizione, desidera ritrovare la propria anima o “sente” quelle altrui, però dall'altra parte dello schermo arrivano briciole di energia e bisogna accontentarsi dei fantasmi dickensiani o delle visioni paranormali del medium George. Curioso, inoltre, che Eastwood si mostri assai critico attaccando frontalmente la categoria di coloro che “parlano con i morti” catalogandoli come (giusto che sia) imbroglioni, e poi arrivi a santificare il suo protagonista sensitivo solo perché decide di smettere di lucrare con questa dote. Va detto, però, che lo sguardo del regista sa essere anche pragmatico, infatti in “Hereafter” non c'è una destinazione precisa o un prevedibile Paradiso su cui approdare, non c'è una comoda strada cattolica da seguire; anzi, il veloce e stereotipato funerale del ragazzino a Londra sembra quasi prendere le distanze con ironia dalla morale cristiana. Dell'ultimo Eastwood apprezziamo l'onesta e l'ambiziosa intenzione di riflettere con umiltà su un argomento tanto indefinibile quanto sacro e inviolabile. Progetto riuscito o tentativo mancato? Per chi scrive, come probabilmente si evince, la seconda. Ciò nonostante, alcuni potrebbero apprezzare questo viaggio contemplativo e gradire la vena malinconica del vecchio Clint; con il quale condividiamo il pensiero circa l'impossibilità di stabilire l'esistenza di un'oltretomba e per cui al di qua della terra ci auguriamo di gioire per lunghi anni ammirando le sue pellicole. Voto: 6